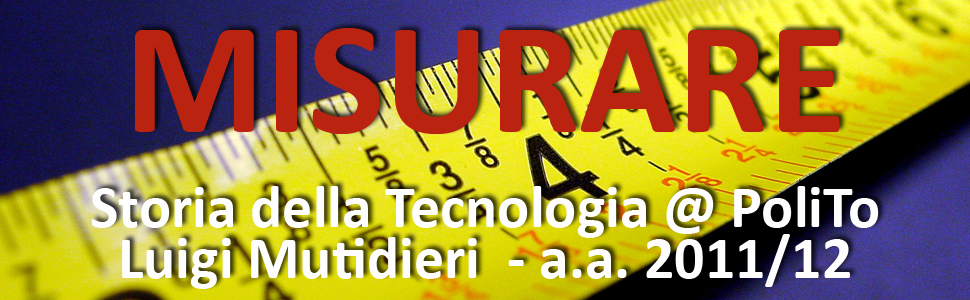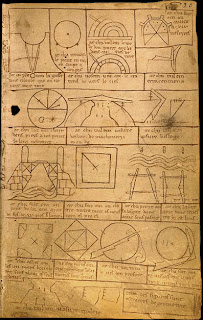Se, come si è già scritto, gli strumenti di misura hanno portato al progresso delle scienze nella rivoluzione scientifica, è anche vero il contrario: i progressi nella comprensione dell'universo hanno portato alla creazione di nuovi strumenti di misura come miglirie di sturmenti già esistenti o per misurare nuove grandezze fisiche. Vediamo alcuni esempi:
Le conoscenze astronomiche sin dall'antichità hanno permesso la creazione di calendari (anche sotto forma di tally stick), meridiane, sestanti, astrolabi.
Gli studi sul pendolo da parte di Galilei e Huygens trovano un'applicazione della proprietà di isosincronismo nella costruzione dell'orologio a pendolo.
La spinta di Archimede, scoperta dall'inventore greco, è alla base del funzionamento della bilancia idrostatica, di cui si ha una descrizione di Galilei ne La Bilancetta.
Gli studi sulla pressione portano alla costruzione dei primi barometri nel Seicento. Il primo, quello di Giovanni Battista Baliani, risale al 1641, seguito nel 1643 da quello di Evangelista Torricelli. Sul principio del barometro funzionano i più semplici altimetri.
I progressi nell'ambito di chimica-fisica sperimentale richiedono una trattazione più rigorosa della temperatura. Se fin al XVII secolo si erano visti solo termoscopi, la padronanza del fenomeno della dilatazione termica o di altre caratteristiche termometriche ha permesso la realizzazione di termometri e relative scale termometriche.
Il mondo dell'elettricità apre nuove frontiere nel mondo degli strumenti di misura. Un esempio è l'effetto Seebeck,
grazie al quale è possibile misurare la temperatura di un corpo
rilevando la differenza di potenziale generata da una termocoppia.
Le nuove grandezze fisiche proprie dei fenomeni elettrici richiedono nuovi strumenti di misura. Un multimetro (o multitester) moderno raccoglie molte funzioni.
La comprensione della natura atomica della materia ha permesso la costruzione dell'orologio atomico (1948), in cui la base del tempo è determinata dalla frequenza di risonanza di un atomo per una accuratezza di 10-9 secondi al giorno . Si è rivista la definizione operativa del secondo (1967) come la durata di 9.192.631.770 periodi di una radiazione caratteristica del cesio-133.