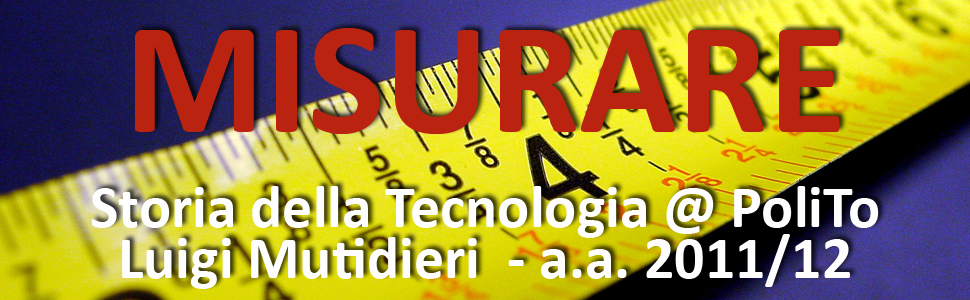Nel mondo industriale il tecnico lavora su macchine prodotte da altri e altrove, macchine costose, che richiedono un certo capitale d'investimento. C'è bisogno di mediazione, all'apprendistato dell'artigiano si sostituisce il
technological transfer delle scuole tecniche; è la nascita del sistema di istruzione tecnica, che porta con sé la normazione, la standardizzazione, la
prototipazione.
La
misura nel XVIII e XIX secolo diviene finalmente sinonimo di standard, volto a favorire la modularità e l'intercambiabilità dei pezzi meccanici (idee nate in ambito militare), nonchè la comunicazione tra gli innumerevoli passaggi della produzione industriale. Se il lavoro non è svolto da un unica persona, ma è un continuo di
lavori successivi, la mediazione all'interno della fabbrica è
fondamentale.

Uno dei simboli - passato inosservato - della rivoluzione industriale è l'
orologio da taschino. Il macchinismo permetterà nel tempo
la strutturazione del lavoro in batterie di macchinari simili
posti in serie e operato su un nastro da un solo tecnico, per un
graduale aumento della produttività (bene prodotto / forza lavoro). Cronometrare le varie fasi della produzione per eliminare i tempi morti è il compito delle figure
organizzative delle fabbriche, i veri interpreti della rivoluzione. In un celebre passo de
La ricchezza delle nazioni (1776), Adam Smith discute la
razionalizzazione del lavoro che diventerà scienza del taylorismo. E' la nascita dell'economia.

"Ho visto una volta una piccola fabbrica in cui erano impiegati solo dieci uomini, e in cui pertanto alcuni svolgevano due o tre mansioni [...]. Queste dieci persone riuscivano a fare fino a 48.000 spilli in un giorno. Pertanto, poiché ognuno faceva la decima parte di 48.000, si può dire che ogni operatore ne fabbricava 4.800 al giorno. Ma se essi avessero lavorato separatamente e indipendentemente, e senza esser stati addestrati a questa particolare attività, nessuno di loro avrebbe potuto fare non dico venti, ma forse neppure uno spillo in un giorno."
 |
| École polytechnique (1794) |
La tecnica non può più fare a meno della matematica; l'
ingegneria, che fino ad allora era solo stata militare, idraulica o civile, comincia a spaziare in tutti i campi del sapere - nascono la fluidodinamica, la termodinamica, l'aviodinamica, l'elettrodinamica, la chimica moderna.
In definitiva, la rivoluzione industriale realizza il passaggio teorizzato da Koyré "Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione": la stima lascia spazio al calcolo e alla misura.